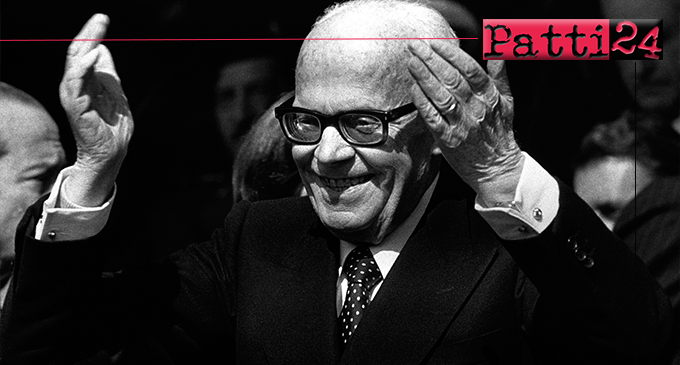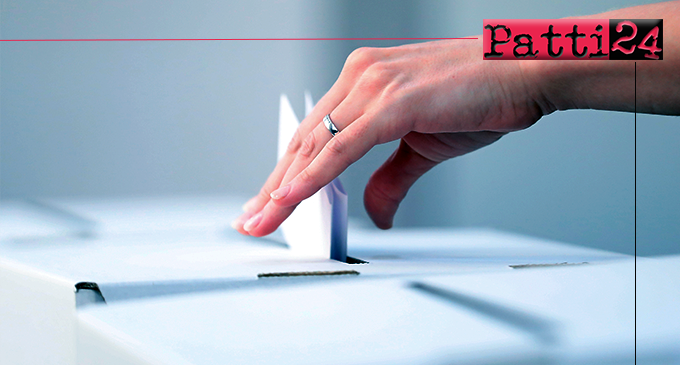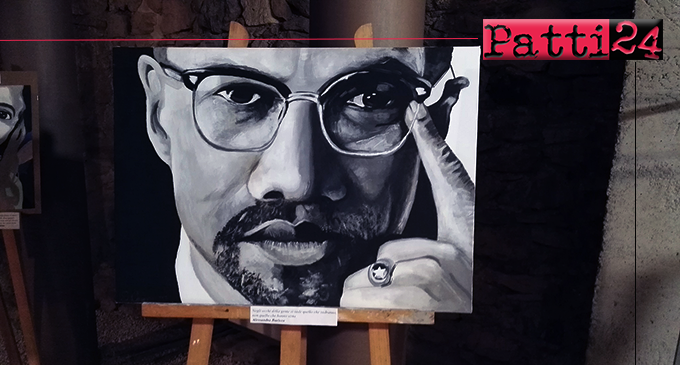GIOCO D’AZZARDO – Tra attività ricreativa e Gambling Disorder

Il gioco d’azzardo, un’attività comune in tutto il mondo, è considerato dalla maggior parte delle persone un passatempo a cui dedicarsi a fini ricreativi o sociali. Tuttavia, se da un lato molti soggetti riescono a gestire frequenza, intensità e coinvolgimento in tale attività, altri sviluppano una forma di gioco problematica che talvolta porta all’instaurarsi un Disturbo da gioco d’azzardo, o Gambling Disorder, definito come “un modello di comportamento di gioco disadattivo e ricorrente che persiste nonostante le conseguenze negative che ne derivano a livello individuale, relazionale, professionale e finanziario”.
Si tratta di una condizione che ha un peso rilevante a livello nazionale e internazionale. In Europa, i tassi di prevalenza di gioco d’azzardo problematico variano dallo 0,2% al 12,3% (Ferrara, Franceschini & Corsello, 2018). In merito al contesto italiano, secondo i dati diffusi dal Ministero della salute nel 2012, circa il 54% della popolazione è coinvolta nel gioco d’azzardo, di questa una percentuale che varia dall’1,3% al 3,8% presenta dei problemi legati al gioco, mentre la stima dei giocatori d’azzardo patologici va dallo 0,5% al 2,2% (Coriale et al., 2015).

Nella quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-V) il Disturbo da gioco d’azzardo viene inserito nella categoria dei “Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction”, sebbene non implichi l’assunzione di sostanze psicoattive. L’attuale classificazione nasce sulla base dell’evidenza di diverse caratteristiche comuni sia al comportamento di gioco patologico che alla dipendenza da sostanze, quali le manifestazioni sintomatiche, le basi genetiche, gli effetti neurobiologici, gli alti tassi di comorbidità e l’efficacia di alcuni trattamenti per entrambe le condizioni. Mettendo in atto il comportamento di gioco, il soggetto sperimenta uno stato di euforia e eccitazione paragonabile a quello legato all’assunzione di alcune sostanze. Da un punto di vista neurobiologico, sia le dipendenze correlate a sostanze che quelle comportamentali condividono un’alterazione delle reti cerebrali della gratificazione.
Inoltre, i giocatori d’azzardo patologici hanno una maggiore probabilità di avere una diagnosi di abuso di alcol o droghe nel corso della vita, e viceversa (Coriale et al., 2015).

Le cause che contribuiscono al superamento del confine tra gioco come attività occasionale e ricreativa e condizione di dipendenza sono molteplici. L’eziologia del disturbo è multifattoriale e risiede in una complessa interazione gene-ambiente. Gli studi condotti in questo ambito hanno individuato diverse anomalie genetiche che aumentano la vulnerabilità alla patologia. Allo stesso modo, sono stati descritti numerosi fattori di rischio ambientale, tra cui precoci esperienze avverse, come abuso e traumi; la gravità del maltrattamento infantile si associa alla precocità d’insorgenza e al decorso del disturbo. Un altro aspetto importante è dato dalle caratteristiche strutturali e situazionali delle attività di gioco (es. accessibilità al gioco, accettazione culturale, dimensione e numero di premi), coinvolte nell’esposizione iniziale e nel mantenimento del comportamento problematico (Ferrara, Franceschini & Corsello, 2018).
Considerando il livello individuale, tra gli aspetti salienti vi sono alcuni tratti di personalità, in particolare l’impulsività e la disregolazione emotiva, e dimensioni temperamentali come la sensation seeking (ricerca di sensaioni) e la novelty seeking (ricerca di novità), che si riferiscono rispettivamente alla tendenza a cercare emozioni forti e stimoli nuovi e inaspettati.

Da un punto di vista neurocognitivo, emerge frequentemente un deficit delle funzioni esecutive, che si esprime attraverso una difficoltà di inibizione del comportamento, di pianificazione, della capacità di prendere decisioni e ridotta flessibilità cognitiva (Coriale et al., 2015). I giocatori patologici hanno una scarsa capacità di progettare sé stessi nel futuro, e mostrano difficoltà a rinunciare a ricompense immediate a cospicue a favore di altre più redditizie a lungo termine (Ciccarelli et al., 2017).
Il Disturbo da gioco d’azzardo è altresì riconducibile a fattori neurobiologici, sono state infatti evidenziate disfunzioni nei sistemi di produzione e rilascio di alcuni neurotrasmettitori come serotonina, dopamina e noradrenalina. Il sistema dopaminergico, ad esempio, è parte del circuito cerebrale della ricompensa (Reward), che modula la risposta soggettiva al piacere e alla gratificazione; una disfunzione a questo livello determina un’alterata sensibilità alle vincite e alle perdite e contribuisce a generare una forte tendenza a cercare situazioni che forniscono alti livelli di piacere e eccitazione. La serotonina, invece, è fondamentale per l’inibizione del comportamento, per cui una bassa quantità di questo neurotrasmettitore correla con elevati livelli di impulsività e ricerca di sensazioni forti (Coriale et al., 2015).

Il mantenimento delle condotte di gioco disadattive ha notevoli conseguenze sul piano individuale, familiare e sociale. Tra le più comuni vi sono la compromissione dei rapporti familiari, accanto alle difficoltà emotive e finanziarie. L’ambiente familiare in cui vi è un soggetto con problemi legati al gioco è spesso caratterizzato da difficoltà economiche, elevati livelli di rabbia e conflittualità, modelli comunicativi poco chiari, ridotta espressione dei sentimenti, confusione di ruoli e responsabilità, e una minore partecipazione ad attività sociali e ricreative. Inevitabilmente, se la condizione persiste nel tempo, i figli sono esposti a una serie di possibili fattori di stress che includono la privazione finanziarie e emotiva, una disciplina incoerente, sicurezza e stabilità ridotte, isolamento, abuso, rifiuto o abbandono da parte dei genitori, con importanti ripercussioni sullo sviluppo individuale (Ferrara, Franceschini & Corsello, 2018).
Contrariamente a quanto si possa pensare, nonostante le conseguenze negative che sperimentano i giocatori d’azzardo patologici, molti non riescono, nonostante ripetuti tentativi, a porre fine a tale problematica, anzi tendono a rincorrere le perdite per tentare di recuperare il denaro perso. Molteplici aspetti contribuiscono al mantenimento delle condotte problematiche, tra questi hanno un ruolo critico la compromissione del processo decisionale, le distorsioni cognitive e il disagio emotivo.
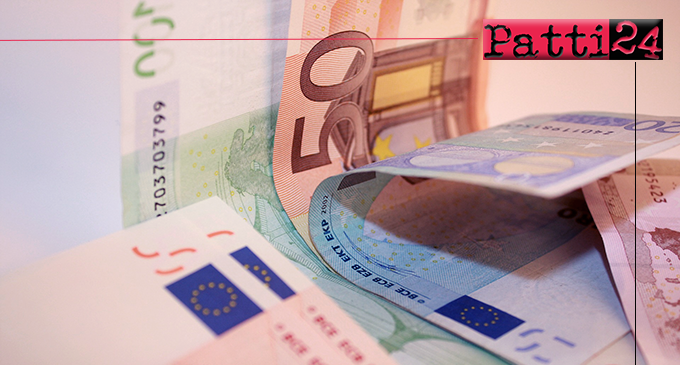
Le distorsioni cognitive sono modalità disfunzionali di elaborazione delle informazioni che contribuiscono a determinare e/o sostenere comportamenti disadattivi. Relativamente al gioco d’azzardo, esse riguardano le credenze erronee sui risultati del gioco e sulla possibilità di influenzarli. Includono, ad esempio, l’illusione di controllo, che si riferisce alla percezione di avere un controllo personale sugli eventi più di quanto sia possibile nella realtà, le credenze superstiziose, ossia la convinzione di poter influenzare il gioco tramite rituali, oggetti o comportamenti specifici, e la fallacia del giocatore, che indica un errore di ragionamento basato su un errato calcolo delle probabilità, per cui il soggetto crede che dopo una serie di eventi se ne verifichi uno alternativo con elevate probabilità. Da qui deriva la tendenza sopravvalutare enormemente la possibilità di vincita di dopo un certo numero consecutivo di perdite.
La ricerca ha inoltre indicato che il Disturbo da gioco d’azzardo si associa frequentemente a disturbi dell’umore e disturbi d’ansia, sebbene la direzionalità tra queste condizioni non è del tutto chiara. Si potrebbe ipotizzare che in presenza di un il disturbo dell’umore o uno stato ansioso, è più probabile che una persona attui comportamenti di gioco per alleviare le emozioni negative e la tensione, e allo stesso tempo i problemi legati al gioco potrebbero contribuire all’insorgenza o al mantenimento del disagio emotivo. Pertanto le condizioni patologiche che si osservano tra i giocatori d’azzardo patologici possono essere sia elementi di rischio per l’insorgenza del disturbo, sia effetti dello stesso (Ciccarelli et al., 2017).

Nonostante l’elevata percentuale di soggetti che sviluppano problemi legati al gioco d’azzardo, pochi di essi chiedono aiuto e ricercano un trattamento. Le motivazioni alla base di tale scelta includono, ad esempio, la convinzione di potercela fare da soli, la vergogna e il senso di colpa, ma anche la poca chiarezza relativa alle strutture in cui recarsi. Pertanto, sarebbe opportuno incrementare da un lato gli sforzi utili a individuare queste persone e offrigli il sostegno necessario, e d’altra parte ottimizzare le strutture di cura.
Bibliografia
Ciccarelli, M., Griffiths, M. D., Nigro, G., & Cosenza, M. (2017). Decision making, cognitive distortions and emotional distress: A comparison between pathological gamblers and healthy controls. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry, 54, 204-210.
Coriale, G., Ceccanti, M., De Filippis, S., Caravasso, C. F., & De Persis, S. (2015). Disturbo da gioco d’azzardo: epidemiologia, diagnosi, modelli interpretativi e trattamento. Rivista di Psichiatria, 50(5), 216-227.
Ferrara, P., Franceschini, G., & Corsello, G. (2018). Gambling disorder in adolescents: what do we know about this social problem and its consequences?. Italian journal of pediatrics, 44(1), 1-5.
dott.ssa Collorafi Valentina
| Patti24 Gruppo Facebook 16.188 membri Iscriviti al gruppo |